Partito Democratico: "continua il silenzio sulla richiesta di Difendere Lucca di segnalare gli insegnanti. Silenzio assenso?"
Partito Democratico: "cont ...
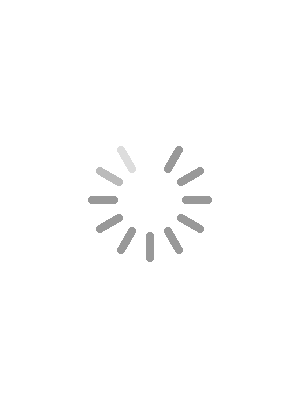
 Il 25 aprile, Festa della Liberazione, ricorda la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista in Italia nel 1945. È una festa nazionale, istituita nel 1946, che celebra la riconquista della libertà e la nascita della Repubblica democratica.
Eppure, ogni anno, non tutte le amministrazioni locali partecipano alle cerimonie ufficiali. In particolare, alcune giunte di destra o con esponenti provenienti dall’area neofascista tendono a disertare le celebrazioni o a ridurne la portata simbolica.
Radici storiche e ideologiche
Molti dirigenti della destra italiana attuale provengono da formazioni politiche nate nel dopoguerra come eredi, diretti o indiretti, del fascismo. Il Movimento Sociale Italiano (MSI), fondato nel 1946, raccoglieva ex gerarchi e simpatizzanti del regime. Per decenni il MSI ha rappresentato la memoria “altra” della storia nazionale: quella dei vinti del 1945.
Sebbene i partiti successivi — come Alleanza Nazionale e poi Fratelli d’Italia — abbiano preso ufficialmente le distanze dal fascismo, la relazione con quella eredità resta complessa. Parte del loro elettorato conserva un’identità nostalgica o un senso di ingiustizia storica per la condanna del fascismo come “male assoluto”.
La retorica della “memoria condivisa”
Negli ultimi anni, molti amministratori di destra giustificano la loro assenza dalle cerimonie sostenendo di voler “superare le contrapposizioni” o di non voler “trasformare la festa in un comizio politico”. Si parla spesso di “memoria condivisa” o “riconciliazione nazionale”.
Ma questa posizione, seppur presentata come inclusiva, spesso maschera un imbarazzo nel condannare apertamente il fascismo. Parte della destra teme che partecipare significhi accettare la lettura storica dell’antifascismo come fondamento della Repubblica, una narrazione da cui preferisce tenere le distanze.
Il piano politico contemporaneo
A livello locale, molti consiglieri o assessori evitano le celebrazioni per non scontentare la base più radicale. Altri scelgono di esserci ma senza simboli o discorsi espliciti.
Il risultato è una divisione evidente: mentre gran parte delle istituzioni civili, scolastiche e sociali celebra la Liberazione come momento fondativo della democrazia italiana, una parte della politica continua a trattarla come un evento “di parte”.
Una festa di tutti, ma non per tutti
In teoria, il 25 aprile è la festa che segna la rinascita del Paese. In pratica, resta un campo di battaglia simbolico. Le assenze di sindaci o consiglieri di destra non sono solo gesti protocollari: riflettono una difficoltà mai del tutto risolta — quella di accettare che la libertà di cui oggi tutti godono nacque dalla sconfitta del fascismo, nonostante una parte della destra politica derivi proprio da quella storia.
Negli ultimi anni, in molte città amministrate da giunte di destra, il 25 aprile è stato affiancato o sostituito da altre commemorazioni, come quelle dedicate a Norma Cossetto o alle vittime delle foibe.
Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi, è diventata un simbolo del martirio “italiano” spesso contrapposto, in modo improprio, alla memoria della Resistenza.
La sua figura, storicamente degna di rispetto, viene però talvolta usata come bandiera politica per riequilibrare la narrazione storica: invece di riconoscere il 25 aprile come festa della libertà, si cerca di spostare l’attenzione sulle sofferenze subite da italiani non comunisti o filofascisti.
Questa strategia costruisce una sorta di “memoria alternativa”, che non nega apertamente la Liberazione ma la relativizza, trasformando il ricordo in una gara tra vittime.
In questo modo, il valore universale del 25 aprile — la fine della dittatura e dell’occupazione — rischia di venire oscurato da una narrazione che divide invece di unire.
Il 25 aprile, Festa della Liberazione, ricorda la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista in Italia nel 1945. È una festa nazionale, istituita nel 1946, che celebra la riconquista della libertà e la nascita della Repubblica democratica.
Eppure, ogni anno, non tutte le amministrazioni locali partecipano alle cerimonie ufficiali. In particolare, alcune giunte di destra o con esponenti provenienti dall’area neofascista tendono a disertare le celebrazioni o a ridurne la portata simbolica.
Radici storiche e ideologiche
Molti dirigenti della destra italiana attuale provengono da formazioni politiche nate nel dopoguerra come eredi, diretti o indiretti, del fascismo. Il Movimento Sociale Italiano (MSI), fondato nel 1946, raccoglieva ex gerarchi e simpatizzanti del regime. Per decenni il MSI ha rappresentato la memoria “altra” della storia nazionale: quella dei vinti del 1945.
Sebbene i partiti successivi — come Alleanza Nazionale e poi Fratelli d’Italia — abbiano preso ufficialmente le distanze dal fascismo, la relazione con quella eredità resta complessa. Parte del loro elettorato conserva un’identità nostalgica o un senso di ingiustizia storica per la condanna del fascismo come “male assoluto”.
La retorica della “memoria condivisa”
Negli ultimi anni, molti amministratori di destra giustificano la loro assenza dalle cerimonie sostenendo di voler “superare le contrapposizioni” o di non voler “trasformare la festa in un comizio politico”. Si parla spesso di “memoria condivisa” o “riconciliazione nazionale”.
Ma questa posizione, seppur presentata come inclusiva, spesso maschera un imbarazzo nel condannare apertamente il fascismo. Parte della destra teme che partecipare significhi accettare la lettura storica dell’antifascismo come fondamento della Repubblica, una narrazione da cui preferisce tenere le distanze.
Il piano politico contemporaneo
A livello locale, molti consiglieri o assessori evitano le celebrazioni per non scontentare la base più radicale. Altri scelgono di esserci ma senza simboli o discorsi espliciti.
Il risultato è una divisione evidente: mentre gran parte delle istituzioni civili, scolastiche e sociali celebra la Liberazione come momento fondativo della democrazia italiana, una parte della politica continua a trattarla come un evento “di parte”.
Una festa di tutti, ma non per tutti
In teoria, il 25 aprile è la festa che segna la rinascita del Paese. In pratica, resta un campo di battaglia simbolico. Le assenze di sindaci o consiglieri di destra non sono solo gesti protocollari: riflettono una difficoltà mai del tutto risolta — quella di accettare che la libertà di cui oggi tutti godono nacque dalla sconfitta del fascismo, nonostante una parte della destra politica derivi proprio da quella storia.
Negli ultimi anni, in molte città amministrate da giunte di destra, il 25 aprile è stato affiancato o sostituito da altre commemorazioni, come quelle dedicate a Norma Cossetto o alle vittime delle foibe.
Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi, è diventata un simbolo del martirio “italiano” spesso contrapposto, in modo improprio, alla memoria della Resistenza.
La sua figura, storicamente degna di rispetto, viene però talvolta usata come bandiera politica per riequilibrare la narrazione storica: invece di riconoscere il 25 aprile come festa della libertà, si cerca di spostare l’attenzione sulle sofferenze subite da italiani non comunisti o filofascisti.
Questa strategia costruisce una sorta di “memoria alternativa”, che non nega apertamente la Liberazione ma la relativizza, trasformando il ricordo in una gara tra vittime.
In questo modo, il valore universale del 25 aprile — la fine della dittatura e dell’occupazione — rischia di venire oscurato da una narrazione che divide invece di unire.
In Europa nel 2026 l’ant ...
Ho letto l’intervento de ...
Il Presidente Giani si sta ...
Lucca – La provincia d ...
Chi Voterà Si al Referend ...
Il centrosinistra lucchese ...
"Il Magistrato Gratteri è ...
Il Tribunale di Bari ha ...
Dopo le contestazioni da p ...
Il confronto tra si e no a ...
Domani la Commissione Co ...
Dopo il comunicato di Di ...
Una bordata di soldi PNRR ...
Difendere Lucca replica ...
Parlare delle foibe signi ...
Il nostro super presidente ...
Difendere Lucca sul Gior ...
Soprattutto nelle ore sera ...